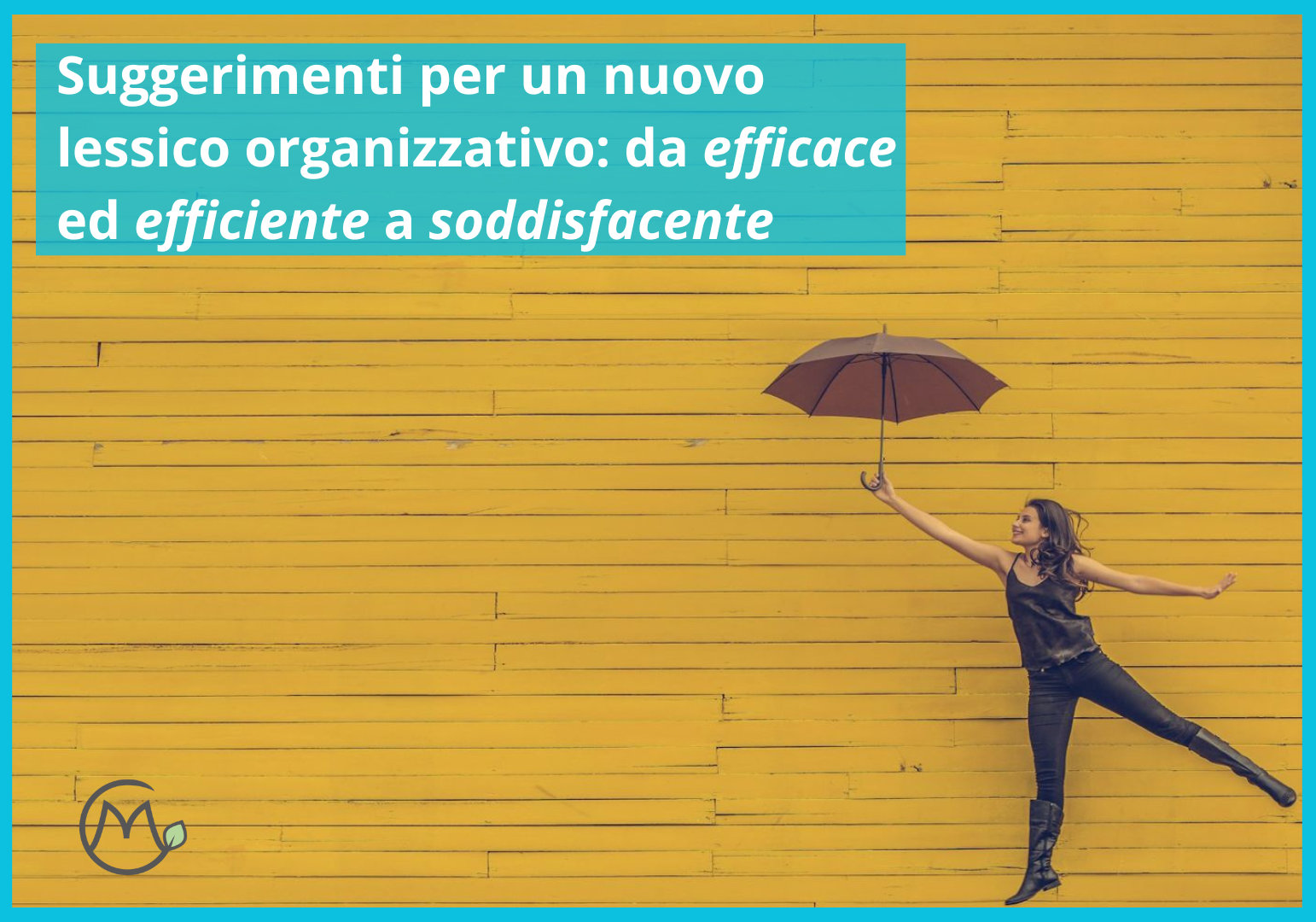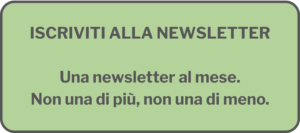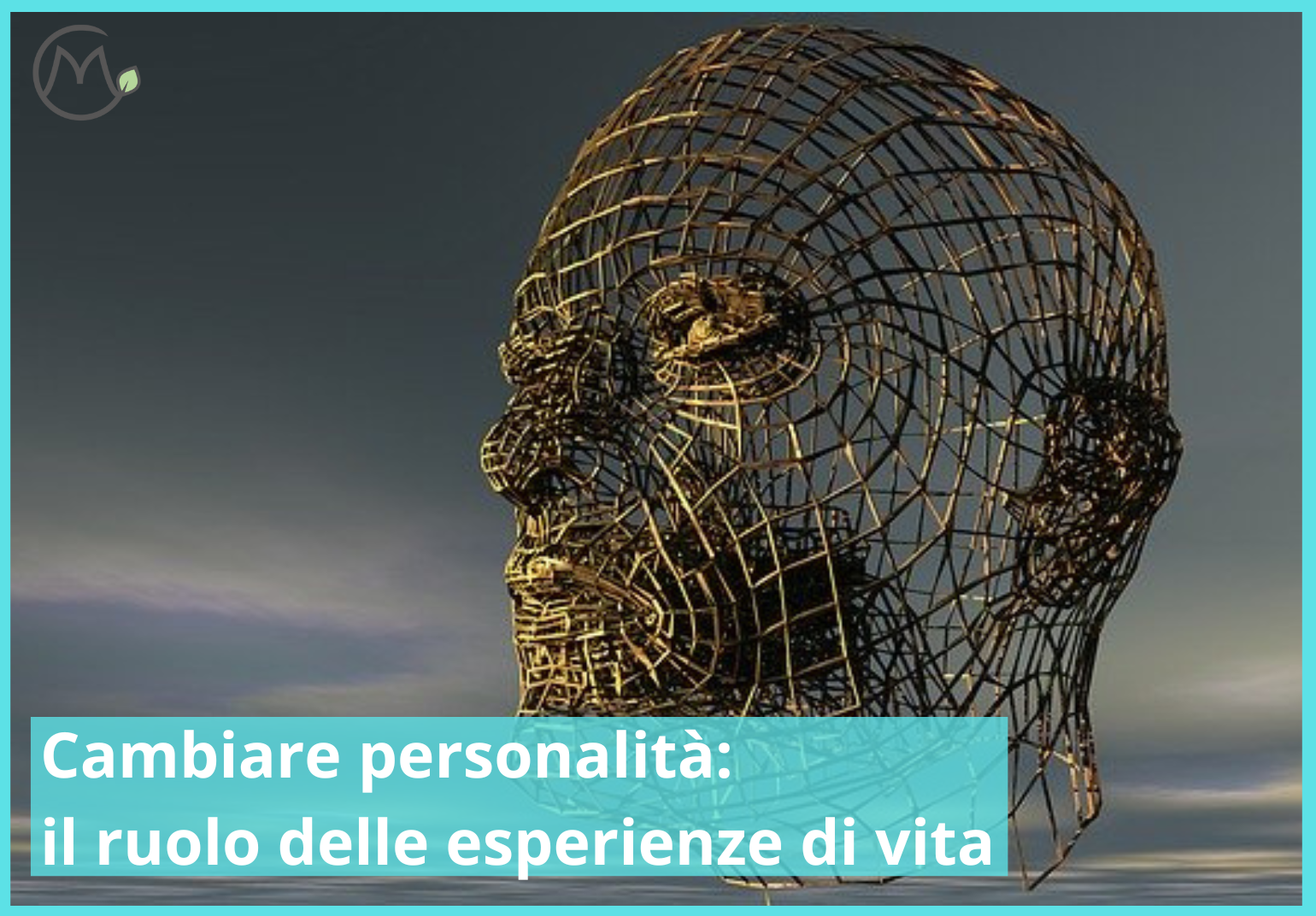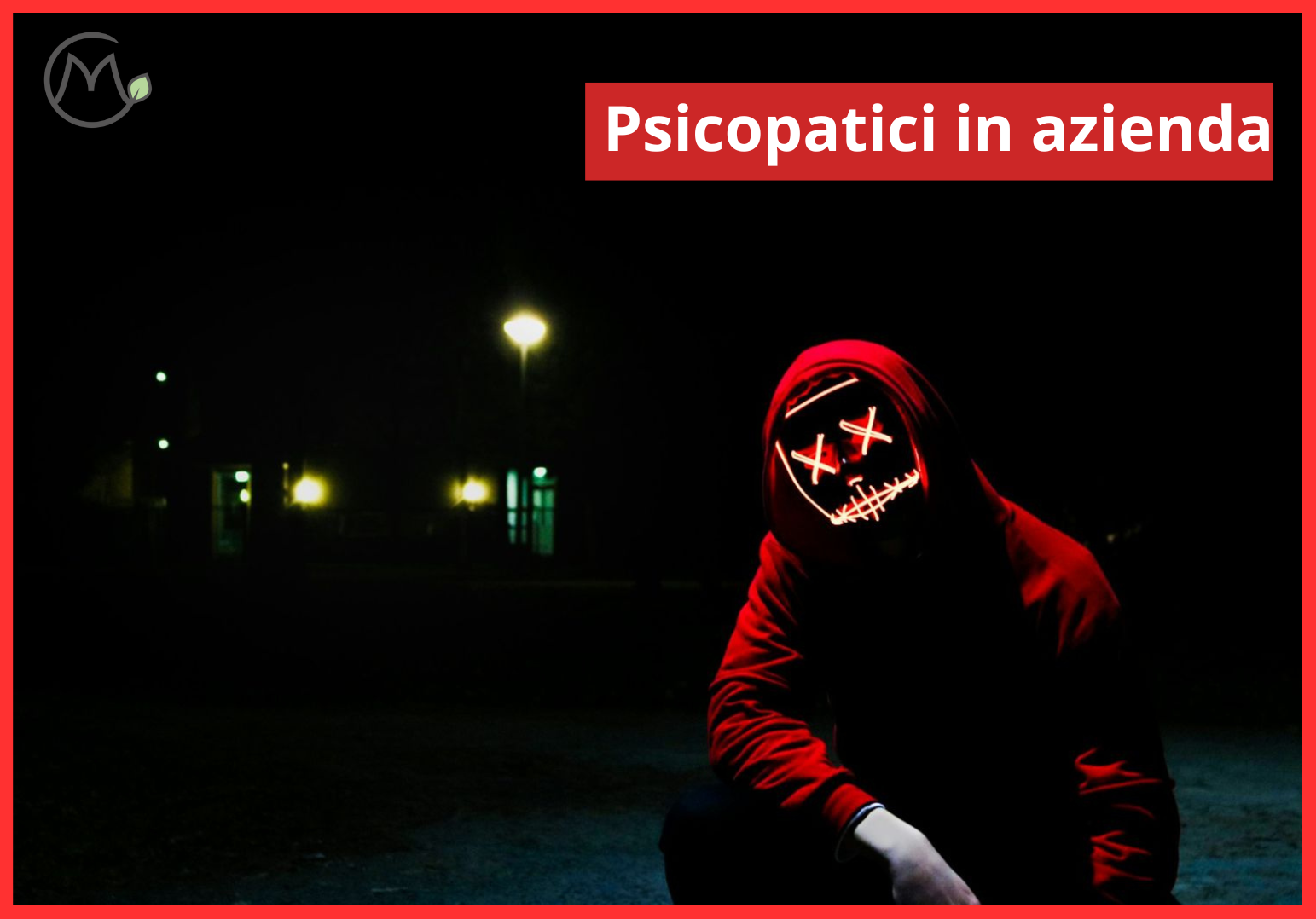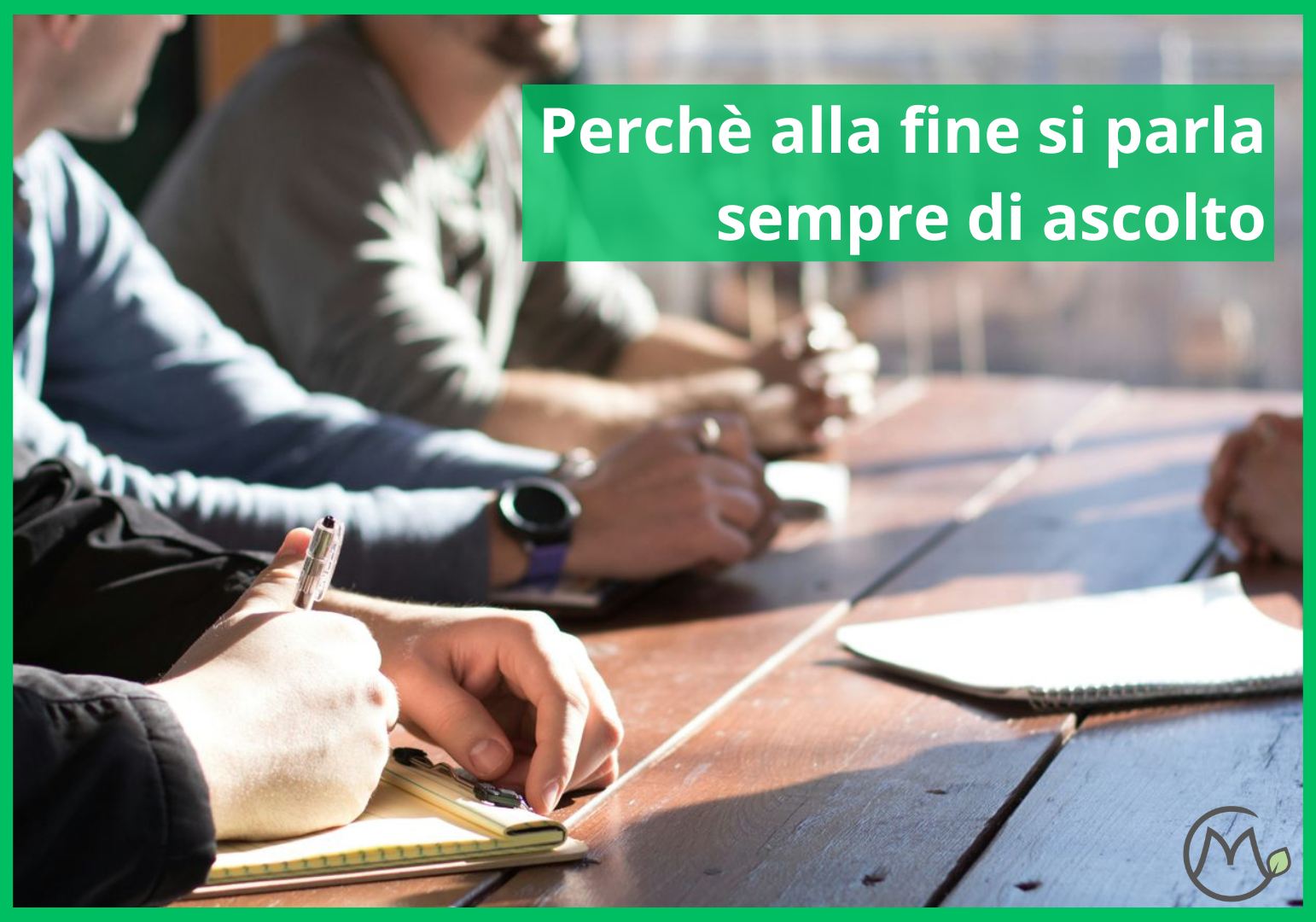Suggerimenti per un nuovo lessico organizzativo: da ‘efficace’ ed ‘efficiente’ a ‘soddisfacente’
Che le parole plasmino la realtà e soprattutto il modo in cui la percepiamo è ormai accertato. Ogni parola porta con sé e in sé significati che sono il frutto di stratificazioni culturali più o meno complesse e lontane nello spazio e nel tempo. E meno esse sono riferite a oggetti concreti e chiaramente ‘circoscrivibili’ più queste stratificazioni tendono ad ampliarsi. Il mondo del lavoro e in particolare delle organizzazioni professionali è pieno di termini che fanno riferimento a concetti astratti, che racchiudono una gamma spesso molto eterogenea di possibili fenomeni.
Ecco perché, dal nostro punto di vista, se si vuole che la trasformazione dell’esperienza lavorativa cui stiamo assistendo conduca verso esiti migliorativi è fondamentale che essa passi anche attraverso un rinnovamento linguistico.
 In un precedente articolo avevamo ad esempio messo provocatoriamente in discussione l’utilizzo della parola “leadership” suggerendo di sostituirla con “provision“, proprio perché meno connotata culturalmente di significati potenzialmente problematici. Questa volta vorremmo soffermarci su un’altra coppia di termini molto utilizzati (per non dire abusati) nel lessico aziendale: il primo è “efficace” e con esso ci si riferisce di solito alla qualità di una qualunque prestazione individuale o collettiva, con un’enfasi particolare sul risultato raggiunto: più esso risponde alle aspettative del committente, più la prestazione sarà considerata efficace. Il secondo è ‘efficiente‘, che invece pone l’accento sul consumo di risorse (tempo, energie, denaro, materiali…) che una determinata attività necessita per essere realizzata: meno ne utilizza, più è considerabile efficiente. Queste due categorie sono dei veri e propri criteri guida, o forse è meglio dire delle istanze alla base dei sistemi industriali moderni e contemporanei. Sono delle spinte non soltanto operative ma prima di tutto psicologiche che permeano la vita organizzativa (e forse non solo) e si possono tradurre nei moniti “Fai meglio!” (in relazione all’efficacia) e “Fai di più!” (in termini di efficienza).
In un precedente articolo avevamo ad esempio messo provocatoriamente in discussione l’utilizzo della parola “leadership” suggerendo di sostituirla con “provision“, proprio perché meno connotata culturalmente di significati potenzialmente problematici. Questa volta vorremmo soffermarci su un’altra coppia di termini molto utilizzati (per non dire abusati) nel lessico aziendale: il primo è “efficace” e con esso ci si riferisce di solito alla qualità di una qualunque prestazione individuale o collettiva, con un’enfasi particolare sul risultato raggiunto: più esso risponde alle aspettative del committente, più la prestazione sarà considerata efficace. Il secondo è ‘efficiente‘, che invece pone l’accento sul consumo di risorse (tempo, energie, denaro, materiali…) che una determinata attività necessita per essere realizzata: meno ne utilizza, più è considerabile efficiente. Queste due categorie sono dei veri e propri criteri guida, o forse è meglio dire delle istanze alla base dei sistemi industriali moderni e contemporanei. Sono delle spinte non soltanto operative ma prima di tutto psicologiche che permeano la vita organizzativa (e forse non solo) e si possono tradurre nei moniti “Fai meglio!” (in relazione all’efficacia) e “Fai di più!” (in termini di efficienza).
Il problema è che tanto l’una quanto l’altra finiscono per mettere al centro dell’attenzione la sole dimensione produttiva dell’esperienza lavorativa, subordinando ad essa tutto il resto.
L’essere umano diventa mero strumento per alimentare la produzione, unico vero obiettivo e ragion d’essere dell’azienda. E se questa prospettiva ci sembra scontata o addirittura ineluttabile (“È ovvio che sia così!“), forse è perché siamo talmente abituati a ragionare in questi termini da non riuscire a riconoscere i pesanti limiti di tale visone. Accettandola abdichiamo implicitamente a coltivare nel lavoro quotidiano anche spazi di realizzazione personale, di apprendimento, di socialità, addirittura di piacere: tutti aspetti che rendono umanamente sostenibile e dignitoso una parte così importante e ‘ingombrante’ della nostra vita.
L’esperienza lavorativa non può essere fondata solo sulla capacità di generare efficacia ed efficienza produttiva, ma anche di restituire soddisfazione ai molteplici bisogni umani a cui è connessa.
Che, sia ben chiaro, è importante non oscurino le esigenze organizzative ma che, d’altro canto, non dovrebbero essere sacrificati in loro nome, pena l’impoverimento se non addirittura la dis-umanizzazione dell’esperienza stessa. A nostro parere, uno dei motivi che sta dietro alla generalizzata demotivazione rilevata e rivelata dalle ricerche è riconducibile proprio alla crescente incapacità del lavoro essere soddisfacente per chi lo compie. Ecco perché continuare a battere il chiodo sul ‘fare di più‘ e ‘fare meglio‘ non porterà molto lontano.