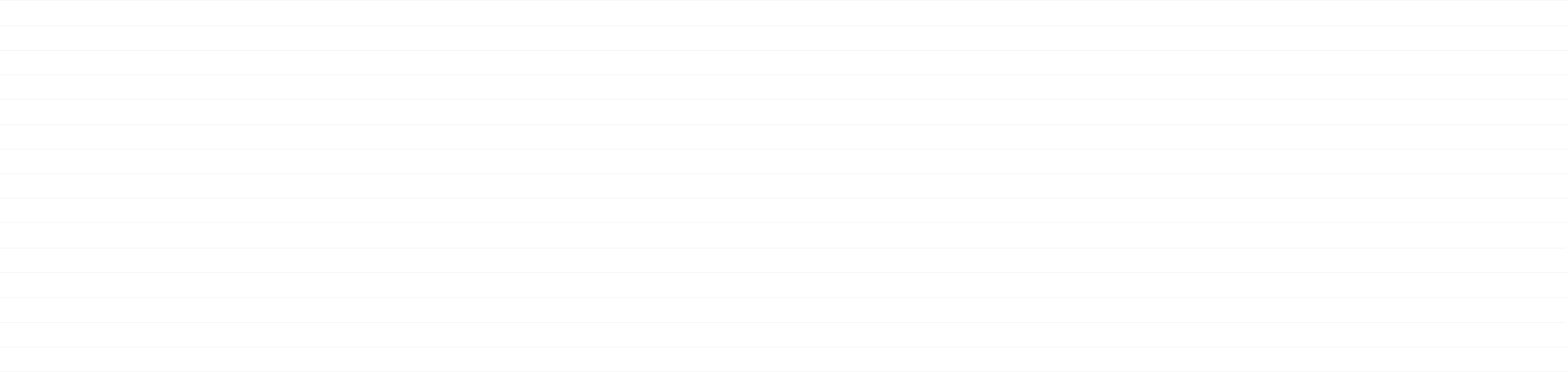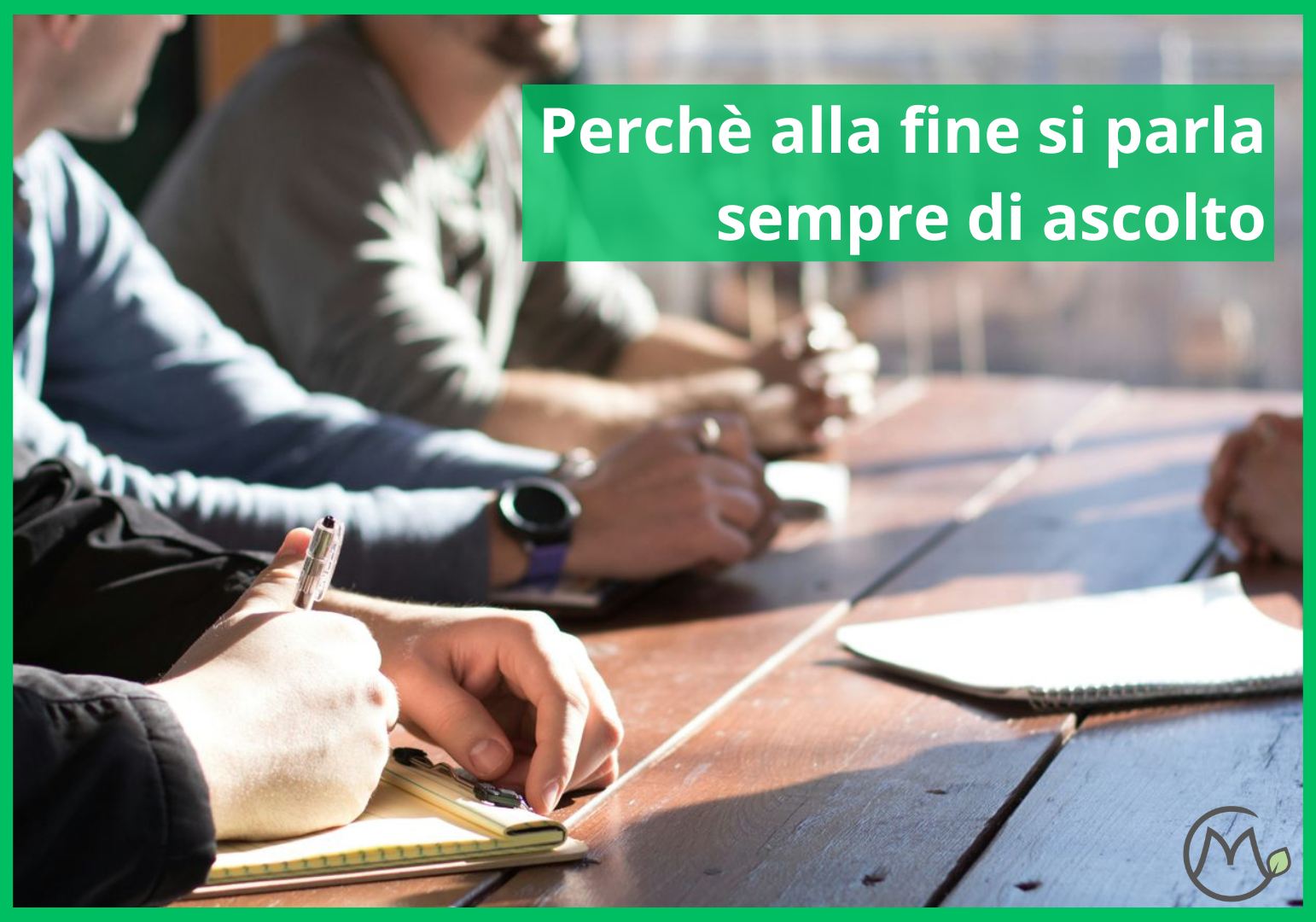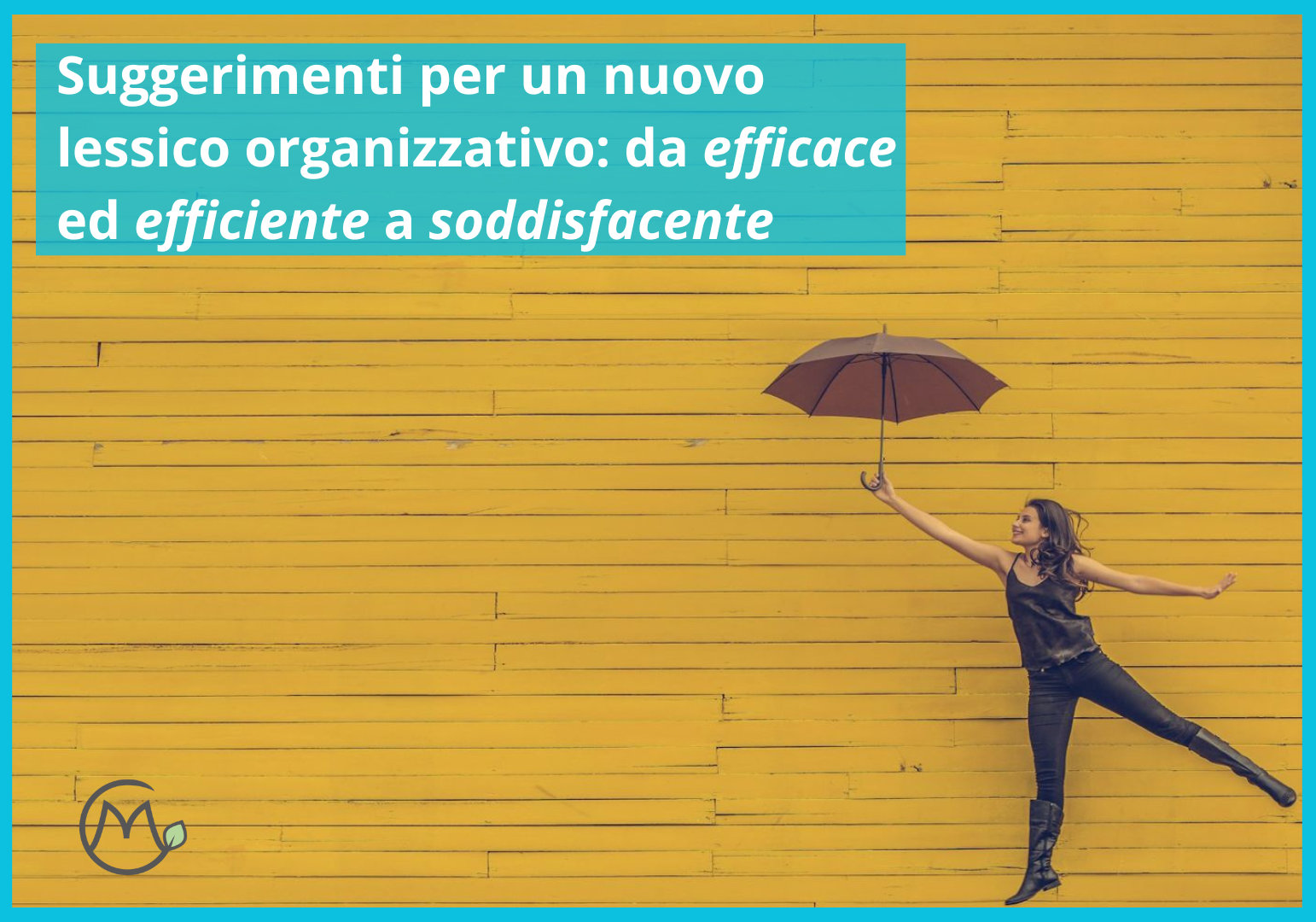Qualche settimana fa un articolo sul Corriere della Sera riportava l'attenzione sul crescente livello di insoddisfazione dei lavoratori italiani. Una recente ricerca dell’Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano rileva, infatti, che solo il 10% dei lavoratori afferma di godere di un livello soddisfacente di benessere fisico, relazionale e mentale. È vero che spesso queste ricerche offrono uno spazio di sfogo alle persone intervistate, però i numeri sono sempre numeri. Il lavoro continua ad essere per troppe persone un'esperienza faticosa e deludente. L’affermazione del fenomeno del “quite quitting” - siccome sono insoddisfatto, e la prospettiva di cambiare lavoro non sembra al momento accessibile, faccio il minimo indispensabile e non chiedetemi di più - rivela la percezione di una trappola. Il periodo successivo al Covid aveva infatti spinto molte persone a cambiare lavoro, nella convinzione e nella speranza di poter accedere a esperienze migliori. Avevamo chiamato questo fenomeno “great resignation”, intravedendo forse una spinta al cambiamento di maggiori dimensioni, quasi “a qualunque costo”, e invece studi successivi avevano ribattezzato il fenomeno, più realisticamente, “great turnover”, e in alcuni casi “boomerang employees”, con evidente riferimento al movimento di ritorno e alla delusione di un tentativo imprudente. Questo trionfo circolare di etichette ci ha portati infine al punto di partenza, alla cocente delusione di una esperienza del lavoro in evidente impasse, nonostante le straordinarie potenzialità dispiegate dalle tecnologie. E allora, di fronte a scenari di crescente incertezza e al corrispondente bisogno di sicurezza e protezione, non rimane che stare dove siamo, facendo quello che dobbiamo, ma niente di più, senza entusiasmo, rinunciando a chiedere a questa esperienza così fondamentale di essere fonte di benessere vitale, di nutrire e riempire la nostra esistenza. Eppure molte organizzazioni credono profondamente nella possibilità di migliorare la condizione di benessere delle persone al lavoro, e molto si fa per alimentare il livello di engagement dei collaboratori. Ma i risultati spesso non sono confortanti. Perché? Credo che due siano le questioni da considerare. Per individuare la prima riprendo la definizione di engagement formulata in una ricerca di Alessandra Mazzei qualche anno fa (qui i riferimenti della ricerca), secondo la quale esso è “un tratto personale di disposizione all’entusiasmo che quando interagisce con fattori situazionali determina uno stato psicologico persistente di assorbimento cognitivo nel proprio lavoro, dedizione emotiva e vigore, cioè energia”. Le organizzazioni che vogliono alimentare engagement naturalmente concentrano la loro attenzione sui “fattori situazionali”, quelli sotto il loro controllo, per offrire condizioni di lavoro in grado di attivare quella disposizione all'entusiasmo che mette in moto l'azione organizzativa. Ma l'elemento spesso trascurato nelle analisi è proprio quest'ultimo: l’entusiasmo. La disponibilità personale ad impiegare l'energia vitale nel lavoro, a “metterci del nostro”, è una condizione che appartiene alla persona, è separata da ciò che l'azienda può fare per attivare o inibire il nostro entusiasmo. I due elementi dell'engagement - la disposizione all'entusiasmo e i fattori situazionali - sono fortemente legati tra loro e interdipendenti, ma sono diversi. Uno appartiene alla persona, l'altro all'ambiente organizzativo in cui opera. Se si trattasse di matematica, diremmo che per cambiare il risultato dobbiamo intervenire non solo sul denominatore ma anche sul numeratore. La questione centrale è che mentre le organizzazioni cercano di intervenire sulle condizioni del lavoro, sono fortemente mutate negli ultimi anni le aspettative soggettive e la rappresentazione di quell'esperienza centrale nella nostra vita che chiamiamo lavoro. Le persone desiderano un equilibrio diverso tra il lavoro e la vita privata, accettano con un crescente grado di insofferenza i climi organizzativi tossici, cercano relazioni nutrienti anche sul lavoro con colleghi e manager, desiderano percorsi di sviluppo professionale e retribuzioni che consentano almeno una vita dignitosa, tanto per citare le voci
Nel mondo della scuola, si sente spesso parlare di innovazione didattica, tecnologie digitali, creatività. Ma cosa accade davvero quando si provano a mettere a terra questi concetti che troppo spesso rimangono chiusi nei dibattiti? Uno dei rischi più sentiti è quello che le tecnologie – invece che essere utilizzati strumenti di emancipazione – diventino nuove forme di limitazione o addirittura di controllo, svuotate di significato e depauperate del loro eventuale potenziale benefico. In questo contesto, lo studio A Resonant Learning (RL) Framework, pubblicato nel 2024 su Education Quarterly Reviews dai ricercatori Charles White e Lawrence Wilde, propone una riflessione ambiziosa e profondamente necessaria: Cosa accadrebbe se, invece di parlare solo di “integrazione delle tecnologie nell’educazione”, provassimo a riportare al centro l’umano, ripensando l’educazione come spazio di risonanza? La loro proposta prende forma attraverso un “framework di apprendimento risonante” che unisce la teoria sociologica della risonanza di Hartmut Rosa con il modello creativo di Graham Wallas. Il punto di partenza assume una prospettiva potremmo dire radicale: l’apprendimento, se vuole essere autentico, non può limitarsi a trasferire contenuti o formare competenze. Deve trasformare chi apprende – e lo può fare solo se si crea una relazione viva, emotiva, aperta all’imprevisto, tra studenti, insegnanti, contenuti, tecnologie, anime e luoghi .Non si tratta, quindi, di aggiungere un'app o una piattaforma al programma educativo. Si tratta di immaginare una scuola capace di “risuonare”, dove le esperienze formative siano segnate da momenti di sorpresa, connessione, meraviglia. Dove gli studenti non si limitino a rispondere correttamente, ma siano toccati da ciò che incontrano, si emozionino, si trasformino. In questa visione, la tecnologia non è il fine, ma uno strumento e un abilitatore per facilitare ambienti capaci di generare esperienze risonanti. Un esempio affascinante che gli autori approfondiscono è quello delle Laptop Orchestras: ensemble musicali in cui studenti usano computer e dispositivi digitali per creare musica collettiva. Non è solo un esercizio tecnologico: è un laboratorio in cui si sperimenta la collaborazione, l’improvvisazione, l’ascolto reciproco, la responsabilità creativa. In altre parole: si fa esperienza della risonanza. Tuttavia, questa prospettiva è tutt’altro che ingenua e tiene conto altresì degli idealismi che nasconde. White e Wilde infatti riconoscono le contraddizioni del sistema scolastico contemporaneo: l’uso delle tecnologie spesso resta superficiale; i docenti si trovano disorientati, a volte isolati; la pressione delle performance e della standardizzazione genera alienazione e burnout. Pertanto, è qui che il concetto di second-order resonance (risonanza di secondo ordine) diventa cruciale: non possiamo e non dobbiamo forzare la risonanza, ma possiamo creare le condizioni perché possa emergere. Il focus deve essere spostato dai discenti al sistema. L’obiettivo deve spostarsi a monte, non a valle. Per permettere agli studenti di risuonare è necessario creare ambienti carichi di significato, rituali educativi che non siano vuote routine, deve generare connessioni autentiche tra persone e saperi. In fondo, pensandoci, questo studio è anche una proposta politica. Chiede di rallentare, di ascoltare, di riconoscere che l’educazione non è solo una questione di contenuti o abilità, ma una pratica relazionale che coinvolge affetti, corpi,memorie. E che ogni volta che uno studente si emoziona davanti a un frammento musicale, o che un insegnante ritrova senso nel proprio mestiere grazie a uno sguardo o a una scoperta condivisa, lì si produce risonanza. Lì accade l’apprendimento. Non è un modello facile da applicare, e forse non vuole esserlo. Ma in un’epoca in cui il rischio è ridurre l’insegnamento a gestione di piattaforme o applicazioni digitali, il framework di Resonant Learning rappresenta un invito potente a reimmaginare la scuola come luogo di possibilità, trasformazione, vita. E voi cosa ne pensate? Per saperne di più, clicca qui!
Che le parole plasmino la realtà e soprattutto il modo in cui la percepiamo è ormai accertato. Ogni parola porta con sé e in sé significati che sono il frutto di stratificazioni culturali più o meno complesse e lontane nello spazio e nel tempo. E meno esse sono riferite a oggetti concreti e chiaramente 'circoscrivibili' più queste stratificazioni tendono ad ampliarsi. Il mondo del lavoro e in particolare delle organizzazioni professionali è pieno di termini che fanno riferimento a concetti astratti, che racchiudono una gamma spesso molto eterogenea di possibili fenomeni. Ecco perché, dal nostro punto di vista, se si vuole che la trasformazione dell'esperienza lavorativa cui stiamo assistendo conduca verso esiti migliorativi è fondamentale che essa passi anche attraverso un rinnovamento linguistico. In un precedente articolo avevamo ad esempio messo provocatoriamente in discussione l'utilizzo della parola "leadership" suggerendo di sostituirla con "provision", proprio perché meno connotata culturalmente di significati potenzialmente problematici. Questa volta vorremmo soffermarci su un'altra coppia di termini molto utilizzati (per non dire abusati) nel lessico aziendale: il primo è "efficace" e con esso ci si riferisce di solito alla qualità di una qualunque prestazione individuale o collettiva, con un'enfasi particolare sul risultato raggiunto: più esso risponde alle aspettative del committente, più la prestazione sarà considerata efficace. Il secondo è 'efficiente', che invece pone l'accento sul consumo di risorse (tempo, energie, denaro, materiali