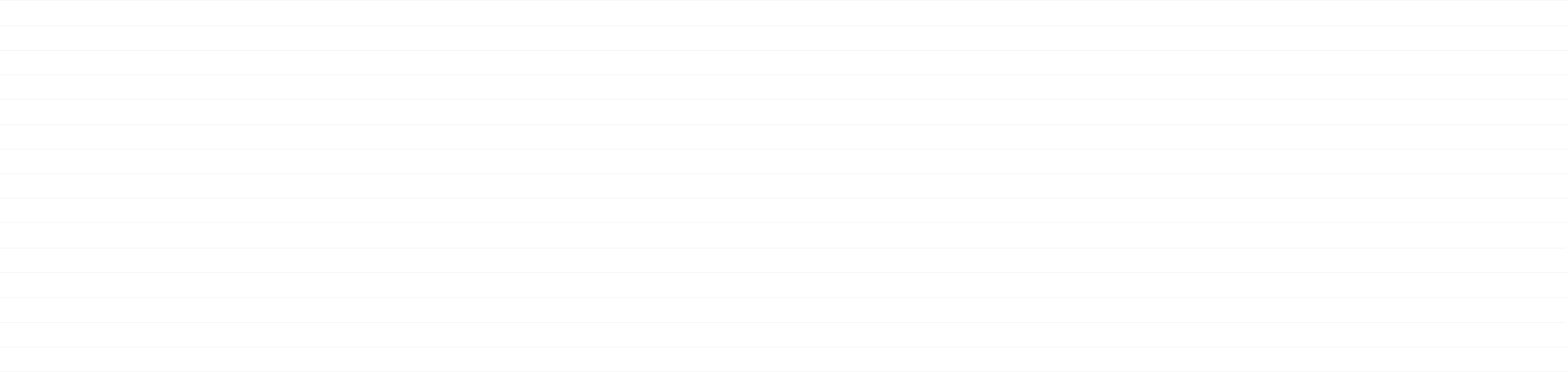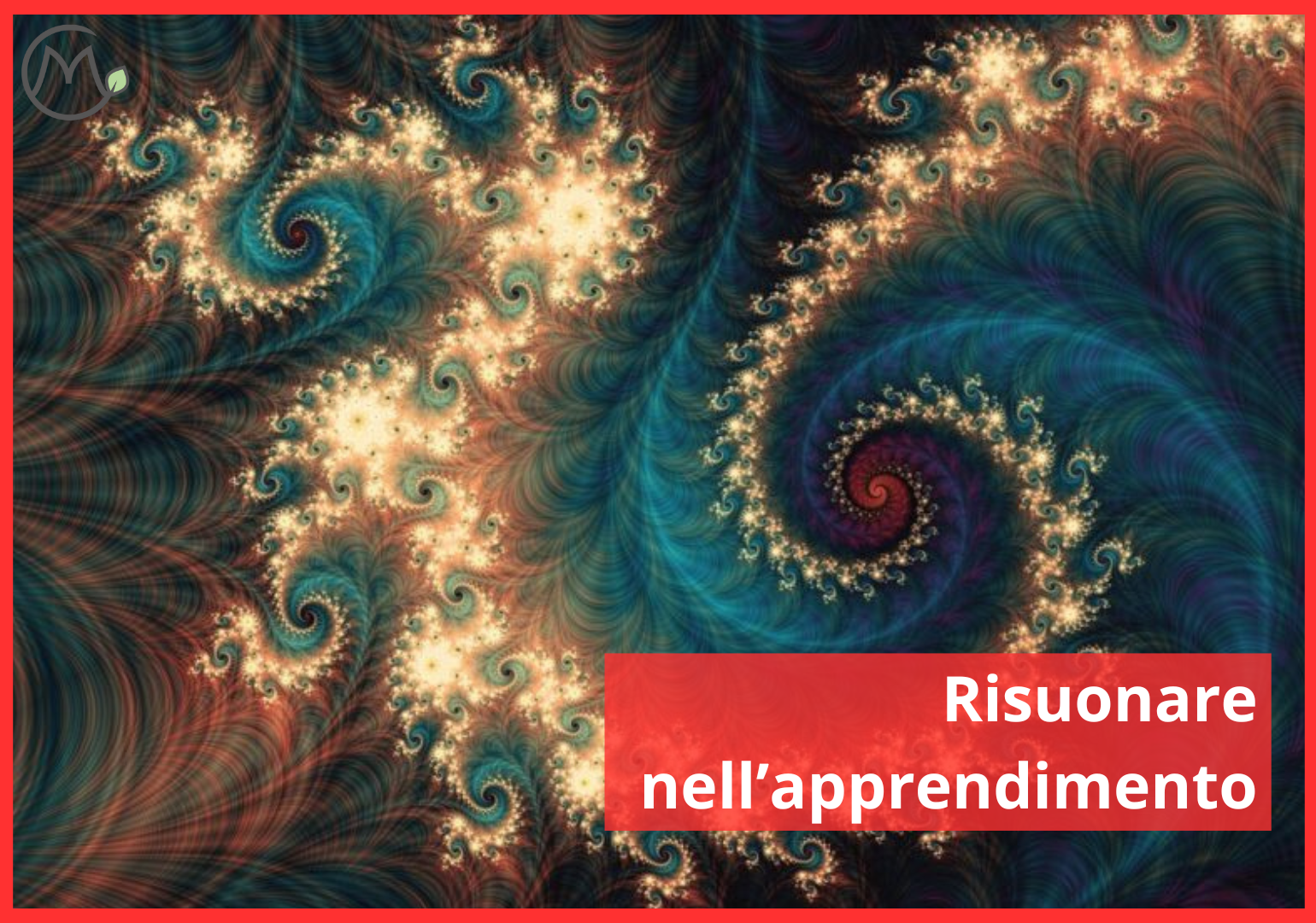Cambiare personalità è possibile? E se sì, cosa lo innesca davvero? Per decenni, le teorie delle personalità hanno promosso l’idea che i tratti individuali – le nostre caratteristiche più profonde – fossero relativamente stabili una volta raggiunta l’età adulta. Tuttavia, sempre più ricerche stanno mettendo in discussione questo assunto, mostrando come la personalità possa invece evolvere nel tempo, persino cambiare talvolta. Ma quanto e in che modo gli eventi di vita incidono su tale cambiamento? Un recente studio condotto da Bühler, Orth, Bleidorn, Weber, Kretzschmar, Scheling e Hopwood (2023) offre un contributo significativo a questa domanda. Si tratta di una meta-analisi preregistrata di 44 studi, che aggrega i dati di oltre 121.000 persone per valutare l’effetto di dieci eventi di vita – dalla nascita di un figlio alla perdita del lavoro, dal matrimonio al pensionamento – su cambiamenti nei Big Five, nell’autostima e nella soddisfazione di vita. Gli interessanti risultati mostrano che gli eventi di vita, inaspettatamente, possono effettivamente modificare la personalità, anche se con effetti tendenzialmente piccoli e specifici. In particolare, è doveroso sottolineare come sorprendentemente gli eventi legati alla sfera lavorativa (come il primo impiego o la laurea) abbiano effetti più consistenti rispetto a quelli nell’ambito affettivo. In particolare, eventi di "guadagno" (es. iniziare una nuova relazione o trovare lavoro) tendono ad associarsi a cambiamenti positivi, mentre eventi di "perdita" (es. divorzio, disoccupazione) mostrano effetti più eterogenei e difficili da prevedere; infatti possono essere sia negativi che positivi in termini di apertura o cambiamento. Questo studio ci invita a superare una visione statica della personalità per abbracciarne un modello dinamico, dove l’esperienza individuale e sociale diventano terreni fertili per trasformazioni anche profonde, sebbene vada detto che questi cambiamenti sono quasi sempre graduali. Questo fatto ci ricorda anche che non tutti gli eventi hanno lo stesso impatto e che comprendere le condizioni e i meccanismi che favoriscono un reale cambiamento resta una sfida aperta per la ricerca non solo accademica ma anche personale. In un contesto sempre più dinamico e complesso, sapere di poter cambiare, sebbene rimanga sempre una sfida, risulta essere una consapevolezza mai scontata e piena di speranza. Nel contesto organizzativo, questa prospettiva può offrire spunti interessanti: i percorsi professionali, i momenti di transizione, o i cambiamenti relazionali all’interno dei team possono non solo modificare comportamenti, ma anche contribuire alla ridefinizione di tratti identitari. Resta però la domanda: come possiamo progettare contesti in grado di facilitare cambiamenti adattivi e maturativi che possano migliorare l’esperienza delle persone? Un buon punto di partenza è quello di permettere non solo a parole come identità e, azzardando, anima di prendere spazio all'interno delle organizzazioni; bensì costruire degli ecosistemi che siano effettivamente e concretamente attenti a queste dimensioni dell'essere. Le organizzazioni non possono e non devono rimanere semplicemente dei luoghi deputati alla produzione di un qualsivoglia tipo di prodotto, servizio o risultato (sebbene sia chiaro che sono questi i fattori che consentono loro di sopravvivere); piuttosto devono divenire degli ambienti in cui le persone possano mettere al servizio di uno scopo le proprie peculiarità e caratteristiche, realizzando uno scopo e realizzandosi nel compierlo. Sebbene questi orizzonti paiano nascondersi dietro logiche sempre più stringenti di competitività e prevaricazione, questi sono i pilastri da tenere in mente e su cui costruire un futuro più silenzioso, gentile e sostenibile, ma non per questomeno impattante. Cosa ne pensate? In quali contesti avete osservato cambiamenti di personalità legati a eventi di vita? Possiamo, come formatori, educatori o manager, favorire questi processi in modo intenzionale? Per saperne di più, clicca qui!
Il significato della vita è un tema che, nell’immaginario collettivo, si lega spesso a figure di spicco, a cui tendiamo a riferirci con l’appellativo di saggi, e a filosofie profonde, come se fosse un concetto da esplorare soltanto in ambiti spirituali o esistenziali. Eppure, la scienza, non accontentandosi dei confini stabiliti dai costumi o dalle abitudini, ha iniziato a indagare il “perché” del nostro stare al mondo in modo sistematico e rigoroso. Secondo il dizionario di Oxford, il “significato della vita” può essere compreso come la percezione di scopo, direzione e valore che un individuo avverte nei confronti della propria esistenza individuale. Questa prospettiva trova un solido sostegno nell’articolo “The Science of Meaning in Life” scritto da Laura King e Joshua Hicks e pubblicato nel 2021 sulla rivista Annual Review of Psychology. Nell’articolo, gli autori illustrano come la ricerca sulla percezione di senso e significato sia diventata un campo florido e quantomai rilevante, non solo a livello personale bensì anche all’interno dei contesti sociali e lavorativi. In particolare, l’articolo individua tre dimensioni principali attraverso cui rilevare la presenza di significato nella propria vita: Comprensione/Coerenza: ovvero la capacità di dare un senso alla propria vita e al mondo, percependo le connessioni tra eventi, idee e persone. Un'alta coerenza è associata a un elevato senso di significato nella propria vita, mentre l'incapacità di ricostruire questa comprensione e questa coerenza può causare stress psicologico e ridurre la percezione di senso; Scopo: ovvero sentire che il proprio comportamento è guidato da obiettivi personali di valore. Gli scopi di vita spesso riflettono aspirazioni a lungo termine che influenzano comportamenti, pensieri e sentimenti quotidiani, ma soprattutto permettono di giustificare le fatiche e gli ostacoli del presente mettendoli al servizio di una meta più nobile nel futuro. Significatività esistenziale: ovvero possedere la convinzione che la propria vita conti e abbia un impatto duraturo e positivo sul mondo. Anche se questa componente può sembrare difficile da misurare, tale percezione soggettiva è fondamentale per sentire che la propria esistenza abbia senso. La ricerca dimostra infatti che le percezioni di significatività sono essenziali per conferire significato alla vita. Queste stesse dimensioni, per quanto fondamentali nella vita, assumono altresì grande importanza anche in ambito organizzativo, perché le organizzazioni che riescono a costruire un senso e un significato intorno a ciò che fanno permettono alle proprie persone di fare lo stesso. Infatti, quando si parla di coerenza e scopo, ci si riferisce alla capacità di individuare un allineamento fra i valori personali e la mission e vision aziendali. Un dipendente che trova corrispondenza tra i propri ideali e quelli dell’organizzazione sente di lavorare in un ambiente coerente con la propria identità, e ciò si traduce spesso in maggiore motivazione, impegno e resilienza (se non addirittura antifragilità) di fronte alle sfide professionali. Questa “coerenza percepita” alimenta la sensazione di non agire in maniera frammentaria, ma di avere un filo conduttore che lega ciò che si fa a ciò che si è in una narrazione coerente che potenzia l’individuo. Parallelamente, la dimensione relazionale e comunitaria del significato esistenziale sono altrettanto cruciali per creare un tessuto di relazioni positive sul luogo di lavoro. Nel momento in cui le persone sentono di partecipare a qualcosa di più grande di loro — come un progetto che abbia impatti positivi sulla società o sull’ambiente — si va ad instaurare in esse un senso di appartenenza che va ben oltre il senso del dovere o l’etica lavorativa. Pertanto, alla luce di questo risulta chiaro come la scienza del significato della vita non sia solo un tema di introspezione personale, ma anche un fattore strategico per lo sviluppo organizzativo, oltre che una questione sempre più
Mi rendo conto che il titolo è un po' forte, facilmente accusabile di clickbaiting. Di fatto però è proprio a questo tema che vorrei dedicare un paio di considerazioni. L'innesco dell'articolo è stato peraltro proprio un titolo, quello del libro dello psicologo Kevin Dutton in cui mi sono imbattuto: "The wisdom of psycopaths". Il testo, a partire dagli studi di Robert Hare (psicologo forense e ricercatore esperto di crimonologia) esplora i tratti distintivi di quella che può essere catalogata come psicopatia (o per essere precisi 'disturbo psicopatico di personalità') e prova a ipotizzare come alcuni di essi, se manifestati all'interno di un perimetro di legalità e integrazione sociale, possano rivelarsi fattori di successo. Soprattutto in determinati contesti, come per esempio quello organizzativo. Secondo l'autore ci sono aspetti della cosiddetta psicopatia che possono in effetti aiutare un individuo a emergere e affermarsi all'interno di un ambiente come quello aziendale: ad esempio un'alta propensione al rischio, una grande capacità di concentrazione e focalizzazione sull'obiettivo e un forte orientamento all'azione. Così come una notevole fiducia nei propri mezzi e una certa spregiudicatezza negoziale. Secondo Dutton queste inclinazioni, se 'dosate' funzionalmente dal soggetto, diventano frecce al suo arco e danno maggiori chance di fare carriera: non è un caso se, in base alle sue ricerche (centinaia di interviste associate a specifici test somministrati in anni di lavoro), fra le professioni in cui maggiormente si riscontrano personalità con tratti psicopatici ci sono proprio Dirigenti e Amministratori Delegati. Il problema è che spesso e volentieri queste 'qualità' si manifestano insieme ad altre caratteristiche molto meno innocue e 'virtuose': ad esempio un basso livello di empatia e scarsa sensibilità nei confronti dei vissuti altrui, una tendenza a mentire e a manipolare l'Altro per il raggiungimento dei propri scopi, una mancanza di scrupoli e sensi di colpa per azioni eventualmente dannose, una dose rilevante di egoismo con spiccata tendenza al narcisismo (ovvero senso grandioso di sé e spinta ad impressionare/affascinare l'interlocutore). È in sostanza molto difficile riuscire a scindere luci e ombre delle personalità psicopatiche e diventa interessante riflettere sul perché esse riescano comunque così facilmente a farsi strada in azienda: una prima spiegazione è proprio la particolare inclinazione di questi profili ad acquisire ruoli di potere che restituiscano visibilità e rilevanza sociale. È un po' come se fossero più motivati di altre tipologie di persone a 'conquistare posizioni', avendo una relazione con la realtà fortemente guidata dall'ambizione. Inoltre la loro carenza di remore e la conseguente baldanza comportamentale, che li porta a fare e dire cose che gli altri si limitano solo a immaginare, finisce per renderli oggetto di ammirazione e quindi identificati come più adatti guidare gruppi. Tanto è vero che si tende a considerarli come dotati di carisma e 'leadership innata'. Un'ulteriore spiegazione risiede per certi versi nei principi stessi del modello di sviluppo capitalista, che propone e implica una visione del mondo degli affari improntata sulla competizione: ha maggiori possibilità di vincere chi rischia di più, chi sa farsi valere, chi arriva prima degli altri; e in una società che ha largamente metabolizzato queste convinzioni (portandole alle sue estreme conseguenze), è inevitabile che tali individui tendano a spiccare e a ottenere incarichi anche di grandi responsabilità. Detta in modo un po' brusco: la loro spietatezza garantisce a investitori e azionisti maggiori profitti e li rende meno titubanti di fronte a scenari complessi o a scelte drastiche. Non a caso, come affermano Floriana Irtelli ed Enrico Vincenti in un articolo scientifico sul tema, quello della 'corporate psychopathy' è un fenomeno che è andato accentuandosi con la seconda metà degli anni '90, con l'avvento cioè della globalizzazione dei mercati e
Qualche settimana fa un articolo sul Corriere della Sera riportava l'attenzione sul crescente livello di insoddisfazione dei lavoratori italiani. Una recente ricerca dell’Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano rileva, infatti, che solo il 10% dei lavoratori afferma di godere di un livello soddisfacente di benessere fisico, relazionale e mentale. È vero che spesso queste ricerche offrono uno spazio di sfogo alle persone intervistate, però i numeri sono sempre numeri. Il lavoro continua ad essere per troppe persone un'esperienza faticosa e deludente. L’affermazione del fenomeno del “quite quitting” - siccome sono insoddisfatto, e la prospettiva di cambiare lavoro non sembra al momento accessibile, faccio il minimo indispensabile e non chiedetemi di più - rivela la percezione di una trappola. Il periodo successivo al Covid aveva infatti spinto molte persone a cambiare lavoro, nella convinzione e nella speranza di poter accedere a esperienze migliori. Avevamo chiamato questo fenomeno “great resignation”, intravedendo forse una spinta al cambiamento di maggiori dimensioni, quasi “a qualunque costo”, e invece studi successivi avevano ribattezzato il fenomeno, più realisticamente, “great turnover”, e in alcuni casi “boomerang employees”, con evidente riferimento al movimento di ritorno e alla delusione di un tentativo imprudente. Questo trionfo circolare di etichette ci ha portati infine al punto di partenza, alla cocente delusione di una esperienza del lavoro in evidente impasse, nonostante le straordinarie potenzialità dispiegate dalle tecnologie. E allora, di fronte a scenari di crescente incertezza e al corrispondente bisogno di sicurezza e protezione, non rimane che stare dove siamo, facendo quello che dobbiamo, ma niente di più, senza entusiasmo, rinunciando a chiedere a questa esperienza così fondamentale di essere fonte di benessere vitale, di nutrire e riempire la nostra esistenza. Eppure molte organizzazioni credono profondamente nella possibilità di migliorare la condizione di benessere delle persone al lavoro, e molto si fa per alimentare il livello di engagement dei collaboratori. Ma i risultati spesso non sono confortanti. Perché? Credo che due siano le questioni da considerare. Per individuare la prima riprendo la definizione di engagement formulata in una ricerca di Alessandra Mazzei qualche anno fa (qui i riferimenti della ricerca), secondo la quale esso è “un tratto personale di disposizione all’entusiasmo che quando interagisce con fattori situazionali determina uno stato psicologico persistente di assorbimento cognitivo nel proprio lavoro, dedizione emotiva e vigore, cioè energia”. Le organizzazioni che vogliono alimentare engagement naturalmente concentrano la loro attenzione sui “fattori situazionali”, quelli sotto il loro controllo, per offrire condizioni di lavoro in grado di attivare quella disposizione all'entusiasmo che mette in moto l'azione organizzativa. Ma l'elemento spesso trascurato nelle analisi è proprio quest'ultimo: l’entusiasmo. La disponibilità personale ad impiegare l'energia vitale nel lavoro, a “metterci del nostro”, è una condizione che appartiene alla persona, è separata da ciò che l'azienda può fare per attivare o inibire il nostro entusiasmo. I due elementi dell'engagement - la disposizione all'entusiasmo e i fattori situazionali - sono fortemente legati tra loro e interdipendenti, ma sono diversi. Uno appartiene alla persona, l'altro all'ambiente organizzativo in cui opera. Se si trattasse di matematica, diremmo che per cambiare il risultato dobbiamo intervenire non solo sul denominatore ma anche sul numeratore. La questione centrale è che mentre le organizzazioni cercano di intervenire sulle condizioni del lavoro, sono fortemente mutate negli ultimi anni le aspettative soggettive e la rappresentazione di quell'esperienza centrale nella nostra vita che chiamiamo lavoro. Le persone desiderano un equilibrio diverso tra il lavoro e la vita privata, accettano con un crescente grado di insofferenza i climi organizzativi tossici, cercano relazioni nutrienti anche sul lavoro con colleghi e manager, desiderano percorsi di sviluppo professionale e retribuzioni che consentano almeno una vita dignitosa, tanto per citare le voci
Nel mondo della scuola, si sente spesso parlare di innovazione didattica, tecnologie digitali, creatività. Ma cosa accade davvero quando si provano a mettere a terra questi concetti che troppo spesso rimangono chiusi nei dibattiti? Uno dei rischi più sentiti è quello che le tecnologie – invece che essere utilizzati strumenti di emancipazione – diventino nuove forme di limitazione o addirittura di controllo, svuotate di significato e depauperate del loro eventuale potenziale benefico. In questo contesto, lo studio A Resonant Learning (RL) Framework, pubblicato nel 2024 su Education Quarterly Reviews dai ricercatori Charles White e Lawrence Wilde, propone una riflessione ambiziosa e profondamente necessaria: Cosa accadrebbe se, invece di parlare solo di “integrazione delle tecnologie nell’educazione”, provassimo a riportare al centro l’umano, ripensando l’educazione come spazio di risonanza? La loro proposta prende forma attraverso un “framework di apprendimento risonante” che unisce la teoria sociologica della risonanza di Hartmut Rosa con il modello creativo di Graham Wallas. Il punto di partenza assume una prospettiva potremmo dire radicale: l’apprendimento, se vuole essere autentico, non può limitarsi a trasferire contenuti o formare competenze. Deve trasformare chi apprende – e lo può fare solo se si crea una relazione viva, emotiva, aperta all’imprevisto, tra studenti, insegnanti, contenuti, tecnologie, anime e luoghi .Non si tratta, quindi, di aggiungere un'app o una piattaforma al programma educativo. Si tratta di immaginare una scuola capace di “risuonare”, dove le esperienze formative siano segnate da momenti di sorpresa, connessione, meraviglia. Dove gli studenti non si limitino a rispondere correttamente, ma siano toccati da ciò che incontrano, si emozionino, si trasformino. In questa visione, la tecnologia non è il fine, ma uno strumento e un abilitatore per facilitare ambienti capaci di generare esperienze risonanti. Un esempio affascinante che gli autori approfondiscono è quello delle Laptop Orchestras: ensemble musicali in cui studenti usano computer e dispositivi digitali per creare musica collettiva. Non è solo un esercizio tecnologico: è un laboratorio in cui si sperimenta la collaborazione, l’improvvisazione, l’ascolto reciproco, la responsabilità creativa. In altre parole: si fa esperienza della risonanza. Tuttavia, questa prospettiva è tutt’altro che ingenua e tiene conto altresì degli idealismi che nasconde. White e Wilde infatti riconoscono le contraddizioni del sistema scolastico contemporaneo: l’uso delle tecnologie spesso resta superficiale; i docenti si trovano disorientati, a volte isolati; la pressione delle performance e della standardizzazione genera alienazione e burnout. Pertanto, è qui che il concetto di second-order resonance (risonanza di secondo ordine) diventa cruciale: non possiamo e non dobbiamo forzare la risonanza, ma possiamo creare le condizioni perché possa emergere. Il focus deve essere spostato dai discenti al sistema. L’obiettivo deve spostarsi a monte, non a valle. Per permettere agli studenti di risuonare è necessario creare ambienti carichi di significato, rituali educativi che non siano vuote routine, deve generare connessioni autentiche tra persone e saperi. In fondo, pensandoci, questo studio è anche una proposta politica. Chiede di rallentare, di ascoltare, di riconoscere che l’educazione non è solo una questione di contenuti o abilità, ma una pratica relazionale che coinvolge affetti, corpi,memorie. E che ogni volta che uno studente si emoziona davanti a un frammento musicale, o che un insegnante ritrova senso nel proprio mestiere grazie a uno sguardo o a una scoperta condivisa, lì si produce risonanza. Lì accade l’apprendimento. Non è un modello facile da applicare, e forse non vuole esserlo. Ma in un’epoca in cui il rischio è ridurre l’insegnamento a gestione di piattaforme o applicazioni digitali, il framework di Resonant Learning rappresenta un invito potente a reimmaginare la scuola come luogo di possibilità, trasformazione, vita. E voi cosa ne pensate? Per saperne di più, clicca qui!
Che le parole plasmino la realtà e soprattutto il modo in cui la percepiamo è ormai accertato. Ogni parola porta con sé e in sé significati che sono il frutto di stratificazioni culturali più o meno complesse e lontane nello spazio e nel tempo. E meno esse sono riferite a oggetti concreti e chiaramente 'circoscrivibili' più queste stratificazioni tendono ad ampliarsi. Il mondo del lavoro e in particolare delle organizzazioni professionali è pieno di termini che fanno riferimento a concetti astratti, che racchiudono una gamma spesso molto eterogenea di possibili fenomeni. Ecco perché, dal nostro punto di vista, se si vuole che la trasformazione dell'esperienza lavorativa cui stiamo assistendo conduca verso esiti migliorativi è fondamentale che essa passi anche attraverso un rinnovamento linguistico. In un precedente articolo avevamo ad esempio messo provocatoriamente in discussione l'utilizzo della parola "leadership" suggerendo di sostituirla con "provision", proprio perché meno connotata culturalmente di significati potenzialmente problematici. Questa volta vorremmo soffermarci su un'altra coppia di termini molto utilizzati (per non dire abusati) nel lessico aziendale: il primo è "efficace" e con esso ci si riferisce di solito alla qualità di una qualunque prestazione individuale o collettiva, con un'enfasi particolare sul risultato raggiunto: più esso risponde alle aspettative del committente, più la prestazione sarà considerata efficace. Il secondo è 'efficiente', che invece pone l'accento sul consumo di risorse (tempo, energie, denaro, materiali
La saggezza è un attributo che da sempre viene attribuito a figure eminenti da cui, almeno in teoria, bisognerebbe farsi guidare. Secondo il dizionario di Oxford è definita come: “L'equilibrio nel comportamento e nel consiglio, che è frutto di una matura consapevolezza ed esperienza delle cose del mondo.” Ad una prima lettura appare lampante come la saggezza incarni due direttrici: una auto-diretta (verso sè stessi) e una etero-diretta (verso gli altri); un moto che agisce prima sull’individuo che la incarna e successivamente su coloro con cui questa persona si relaziona. Tuttavia, per quanto evocativa, la saggezza è una dimensione dell’essere che risulta difficile da indagare, soprattutto con gli strumenti riduzionistici della logica ‘classica’. Eppure c’è chi ha provato a muoversi in questo territorio incerto con rigore scientifico… Proprio quest’anno, un numero nutrito di ricercatori guidati da Maksim Rudnev dell’Università Canades e di Waterloo, ha pubblicato un’interessante articolo su Nature Communications che si pone l’ambizioso obiettivo di domandarsi quali siano le dimensioni che veicolano la percezione della saggezza, ovvero, quali siano le caratteristiche che una persona dovrebbe possedere per essere percepita come saggia. Lo studio, condotto su uncampione di 12 paesi appartenenti a 5 continenti diversi, ha fatto emergere due dimensioni principali: l’orientamento riflessivo e la consapevolezza socio-emotiva. Per orientamento riflessivo si intende principalmente la capacità di affrontare i problemi avvalendosi del pensiero analitico; ma attenzione, ciò non significa limitarsi a una semplice applicazione della logica. Questo tipo di orientamento richiede anche la capacità di fermarsi, riflettere e considerare una varietà di prospettive (convergenti e, forse soprattutto, divergenti) prima di prendere una decisione. Tale postura enfatizza e sottolinea la capacità diregolare le emozioni personali, ascoltandole, comprendendole e accettandole, per evitare che influenzino in modo negativo le decisioni; inoltre, consente di apprendere dall’esperienza e di applicare le lezioni imparate da essa in situazioni nuove. La mente riflessiva, quindi, non è solo logica, ma anche meditativa e lungimirante, cioè in grado di prevedere le conseguenze delle proprie azioni valutando attentamente ogni aspetto della situazione. La consapevolezza socio-emotiva invece evidenzia l’importanza di connettersi con gli altri in modo profondo e rispettoso. Questa capacità non riguarda solo il comprendere le emozioni degli altri, ma anche l’avere empatia e umiltà: qualità che permettono di entrare in sintonia con gli altri e di offrire sostegno senza giudizio. La consapevolezza socio-emotiva aiuta a evitare che l’ego o la rigidità personale ostacolino il rapporto con gli altri, promuovendo relazioni basate sulla comprensione reciproca e sul rispetto. È attraverso questo aspetto "del cuore" che una persona saggia può agire non solo per il proprio bene, ma anche per il bene collettivo. Riteniamo che queste due dimensioni, senza che esse semplifichino eccessivamente la questione (per approfondire vi rimandiamo direttamente alla consultazione del paper), se integrate nell’agire organizzativo possano generare impatti operativi e culturali in grado di modificare profondamente i contesti lavorativi, migliorandoli. E voi cosa ne pensate? Vi vengono in mente ulteriori dimensioni della saggezza? Vi capita di riscontrare persone o comportamenti ‘saggi’ nella quotidianità professionale? Per saperne di più, clicca qui!
Mentre registravamo una puntata dedicata alla salute mentale nei contesti lavorativi per il nostro podcast WIP – Work In Progress, l’ospite (Biancamaria Cavallini, psicologa del lavoro e Direttrice Scientifica di Mindwork) ci ha fatto notare una cosa che ho trovato molto interessante. Faccio un piccolo passo indietro. Bianca stava rispondendo a una domanda relativa alle pratiche quotidiane che possono aiutarci a prevenire gli effetti collaterali dello psico-stress a cui siamo sottoposti, non solo mentre lavoriamo. La sua riflessione è stata più o meno questa: partendo dal presupposto che non esistono in senso assoluto routine giuste o sbagliate, è però di per sé curioso constatare come non ce ne siano di socialmente diffuse e accettate, come accade per la sfera corporea. E ci ha fatto un esempio lampante: di solito consideriamo come parte integrante della nostra vita lavarci i denti almeno una volta al giorno, fin dall'infanzia. Non ci sforziamo di farlo, non dobbiamo trovare particolari escamotage per ricordarcene né aderire ad alcun complicato sistema di credenze per considerare questo gesto utile alla nostra salute. Semplicemente sappiamo che la sua ripetizione giornaliera contribuisce all’igiene dei nostri denti: non ci aspettiamo effetti miracolosi dalla sera alla mattina e siamo consapevoli che la differenza sta proprio nella continuità nel tempo di quel ‘rito’. Accettiamo inoltre il fatto che potremmo comunque aver bisogno di una qualche manutenzione straordinaria, ma proprio per questo quella ordinaria è fondamentale. Tutto molto semplice. Eppure sfido il lettore a trovare un corrispettivo del tooth brushing (maledetti inglesismi!) per la tutela della salute mentale: una piccola pratica giornaliera, condivisa su larga scala, che aiuti a quietare e ripulire la mente dal caos e della ‘scorie’ che così facilmente intercettiamo. Forse è difficile identificarla perché siamo culturalmente poco abituati a ragionare in termini di prevenzione in relazione a questa ‘dimensione’. Essendo meno solida e quindi più sfuggente finiamo per trascurarla, con tutti gli effetti collaterali che ciò comporta. La nostra ospite ha concluso il suo intervento invitando allora gli ascoltatori a identificare, pensando all’esperienza personale, un’attività capace di restituire piacere e relax: ascoltare musica, leggere, fare a maglia, passeggiare… Un’azione che abbia come unico intento il gusto dell’azione stessa, senza secondi fini o intenti performativi. Bene, quella può diventare un ottimo punto di partenza per consolidare la propria routine d’igiene mentale, a cui dare perlomeno lo stesso valore della cura riservata ai denti. Il ben-essere, dentro e fuori dai contesti lavorativi, è il frutto di tanti invisibili e irrisori comportamenti che nondimeno, lentamente, indirizzano e plasmano quella che chiamiamo e percepiamo come qualità della vita. Per contribuire al passaggio dall’igiene dentale a quella mentale (senza però smettere di lavarsi i denti, sia ben chiaro!) mettiamo a disposizione una breve e semplice pratica meditativa guidata, auto-somministrabile alla bisogna e senza nessun effetto collaterale: il nostro dentifricio biologico al gusto mindfulness 😜! ASCOLTA LA TRACCIA