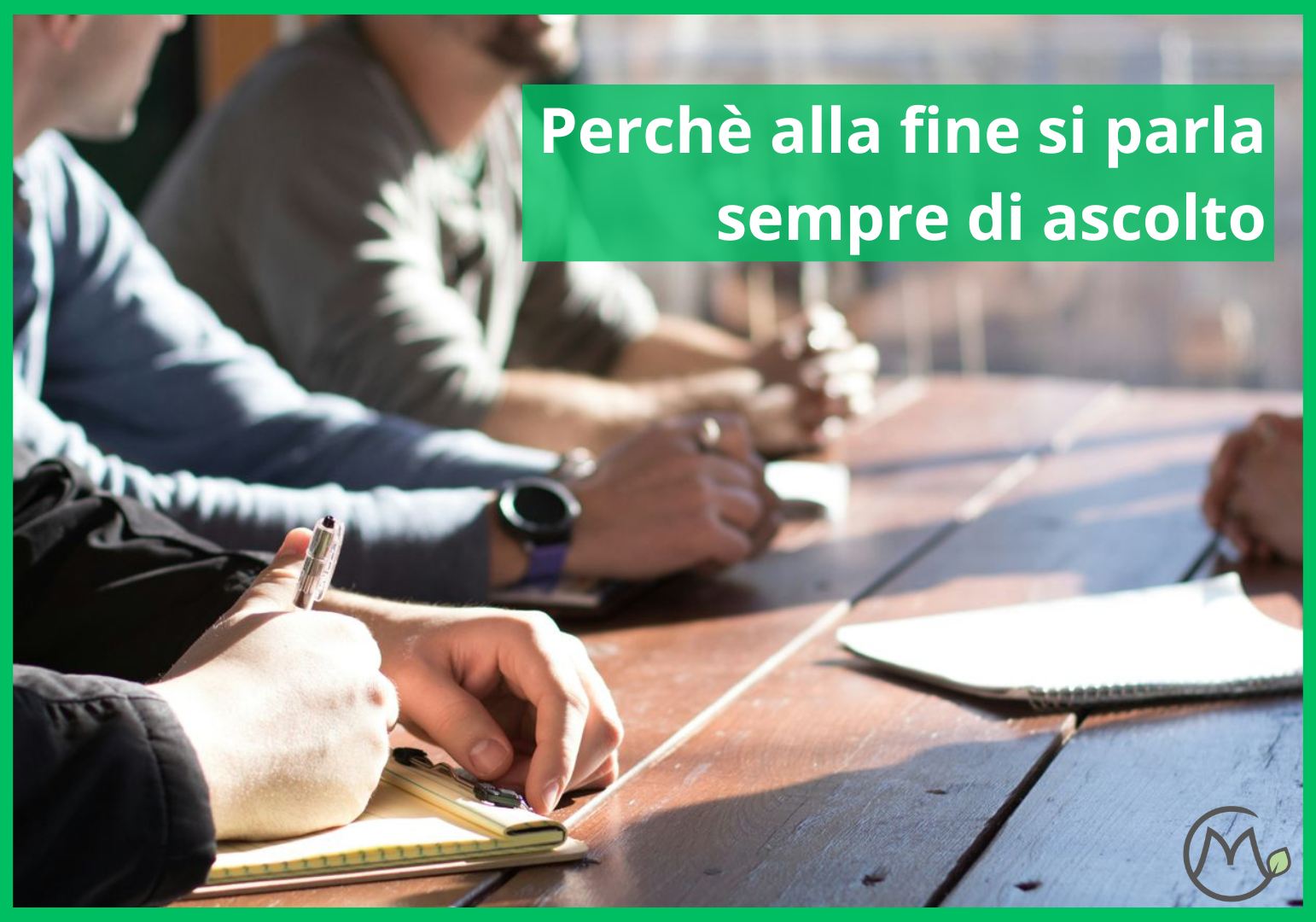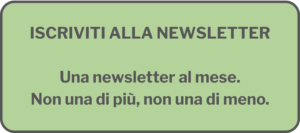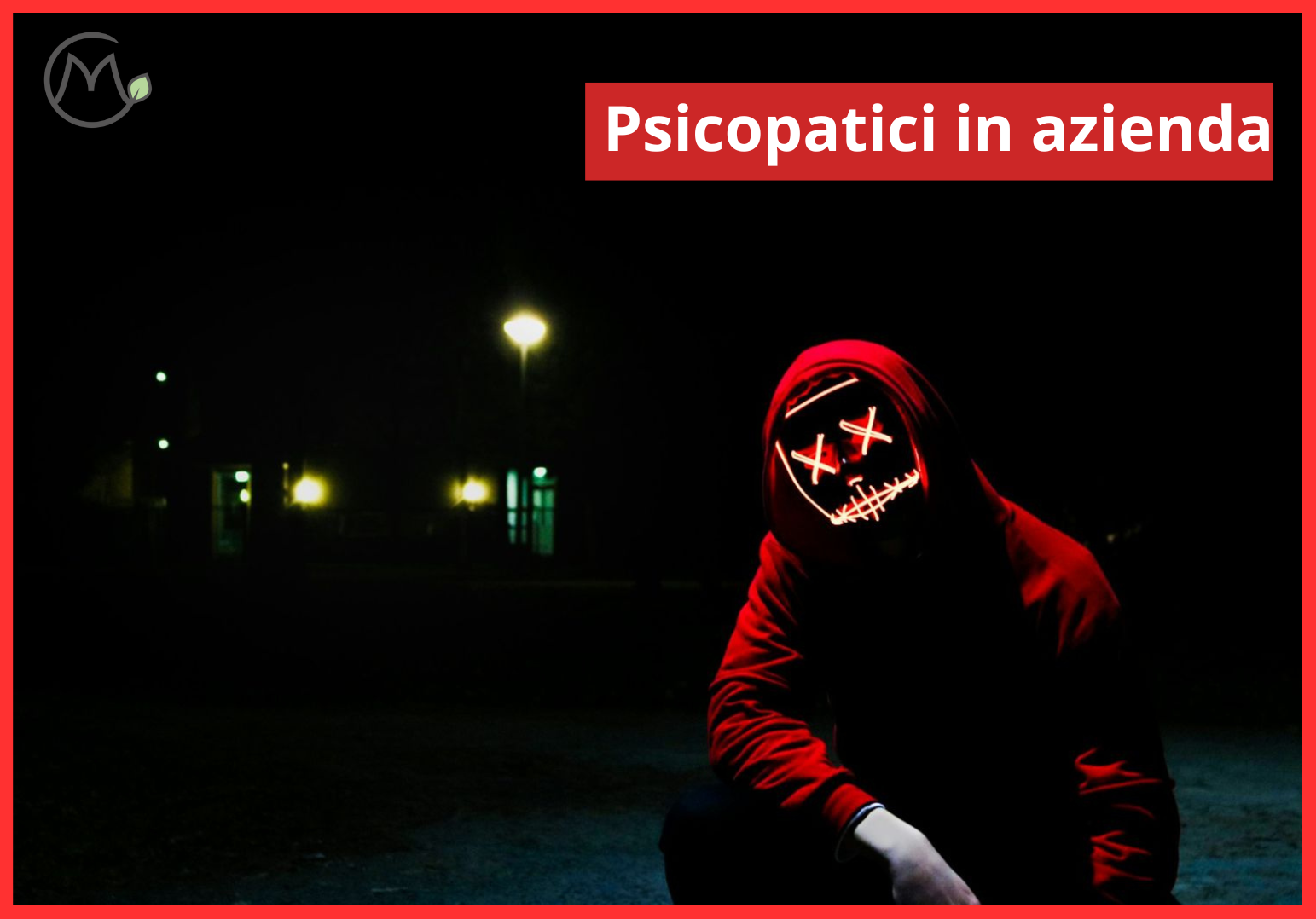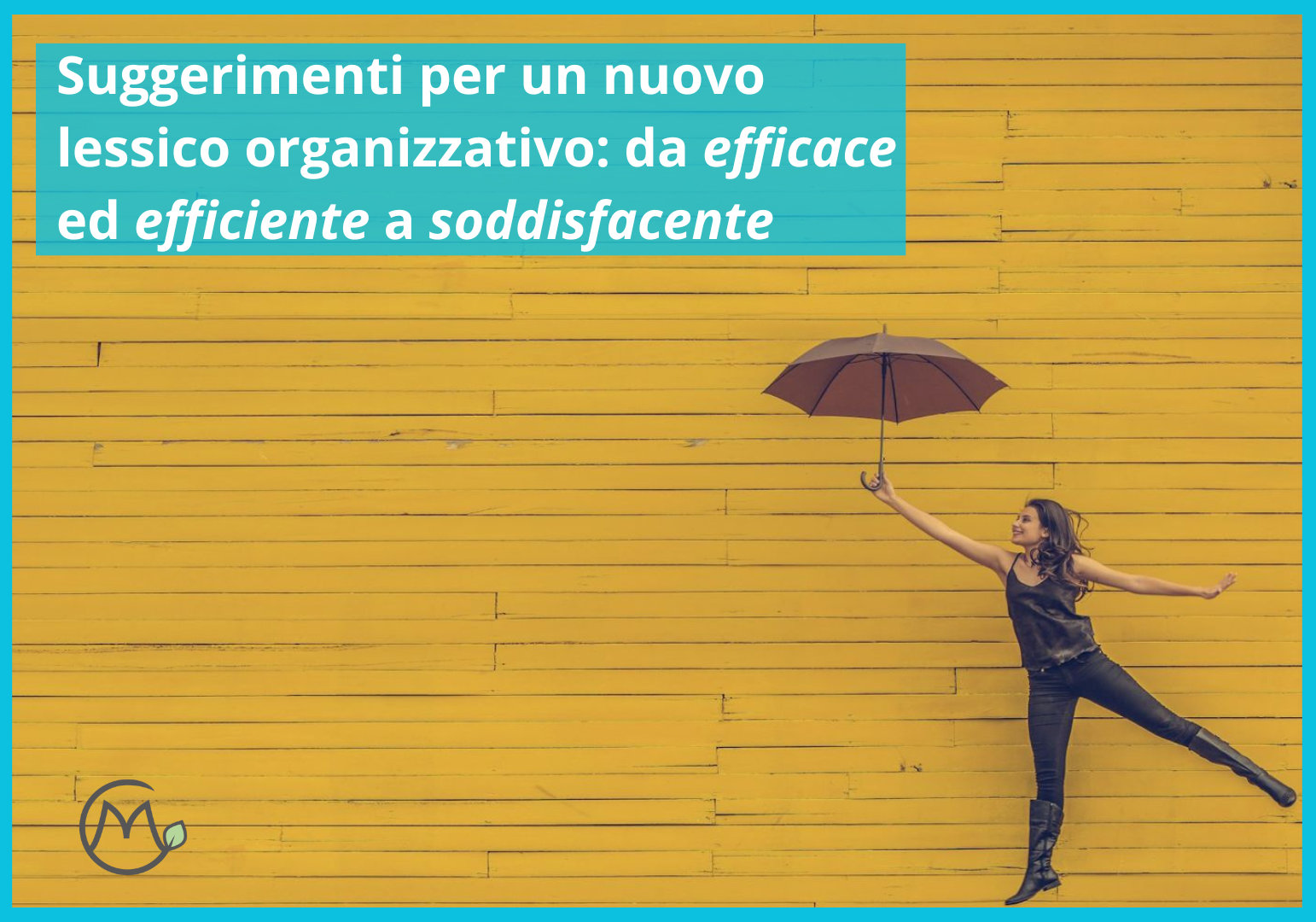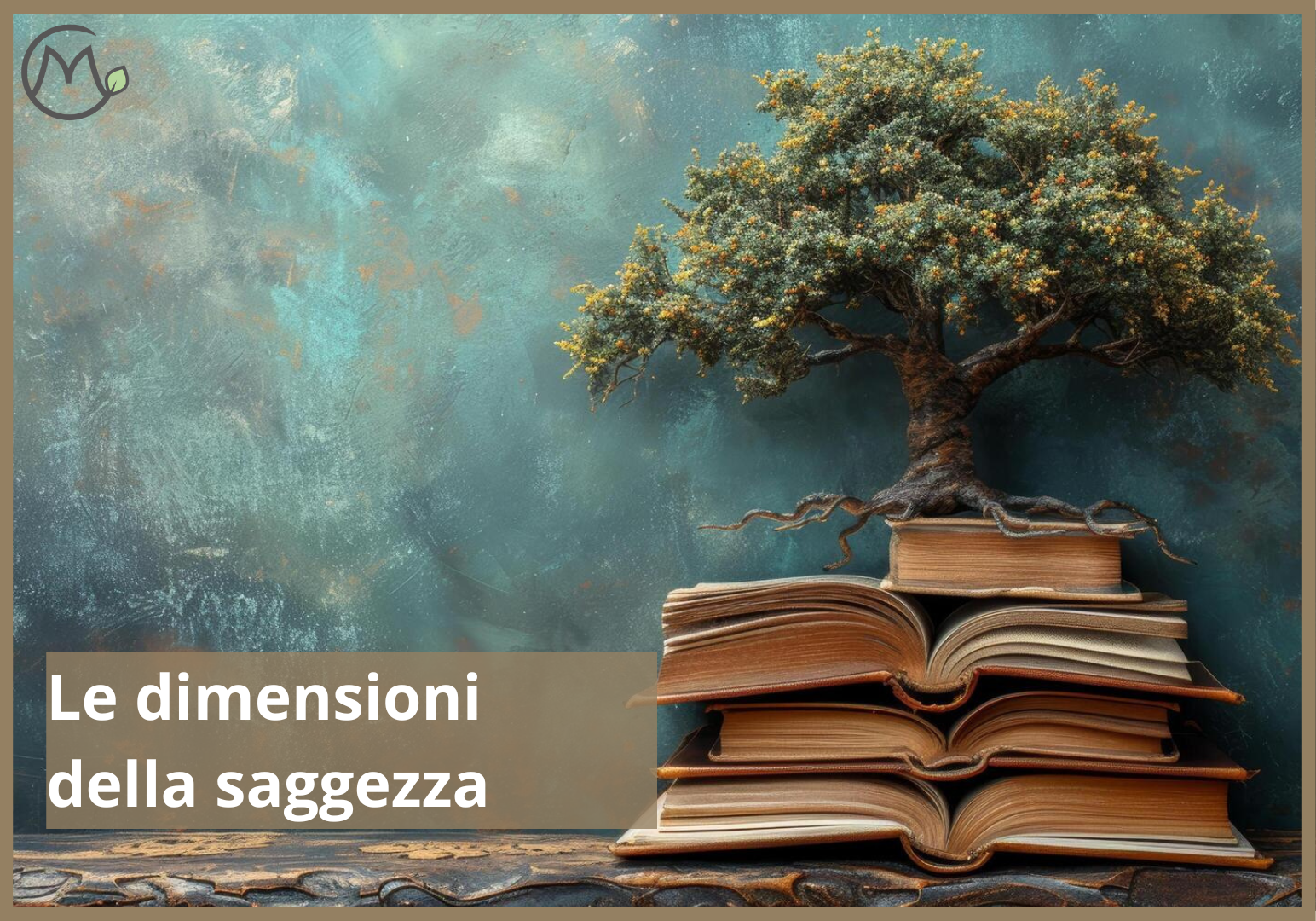Qualche settimana fa un articolo sul Corriere della Sera riportava l’attenzione sul crescente livello di insoddisfazione dei lavoratori italiani. Una recente ricerca dell’Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano rileva, infatti, che solo il 10% dei lavoratori afferma di godere di un livello soddisfacente di benessere fisico, relazionale e mentale. È vero che spesso queste ricerche offrono uno spazio di sfogo alle persone intervistate, però i numeri sono sempre numeri. Il lavoro continua ad essere per troppe persone un’esperienza faticosa e deludente.

L’affermazione del fenomeno del “quite quitting” – siccome sono insoddisfatto, e la prospettiva di cambiare lavoro non sembra al momento accessibile, faccio il minimo indispensabile e non chiedetemi di più – rivela la percezione di una trappola. Il periodo successivo al Covid aveva infatti spinto molte persone a cambiare lavoro, nella convinzione e nella speranza di poter accedere a esperienze migliori. Avevamo chiamato questo fenomeno “great resignation”, intravedendo forse una spinta al cambiamento di maggiori dimensioni, quasi “a qualunque costo”, e invece studi successivi avevano ribattezzato il fenomeno, più realisticamente, “great turnover”, e in alcuni casi “boomerang employees”, con evidente riferimento al movimento di ritorno e alla delusione di un tentativo imprudente.
Questo trionfo circolare di etichette ci ha portati infine al punto di partenza, alla cocente delusione di una esperienza del lavoro in evidente impasse, nonostante le straordinarie potenzialità dispiegate dalle tecnologie. E allora, di fronte a scenari di crescente incertezza e al corrispondente bisogno di sicurezza e protezione, non rimane che stare dove siamo, facendo quello che dobbiamo, ma niente di più, senza entusiasmo, rinunciando a chiedere a questa esperienza così fondamentale di essere fonte di benessere vitale, di nutrire e riempire la nostra esistenza.
Eppure molte organizzazioni credono profondamente nella possibilità di migliorare la condizione di benessere delle persone al lavoro, e molto si fa per alimentare il livello di engagement dei collaboratori. Ma i risultati spesso non sono confortanti. Perché?
Credo che due siano le questioni da considerare.
Per individuare la prima riprendo la definizione di engagement formulata in una ricerca di Alessandra Mazzei qualche anno fa (qui i riferimenti della ricerca), secondo la quale esso è “un tratto personale di disposizione all’entusiasmo che quando interagisce con fattori situazionali determina uno stato psicologico persistente di assorbimento cognitivo nel proprio lavoro, dedizione emotiva e vigore, cioè energia”. Le organizzazioni che vogliono alimentare engagement naturalmente concentrano la loro attenzione sui “fattori situazionali”, quelli sotto il loro controllo, per offrire condizioni di lavoro in grado di attivare quella disposizione all’entusiasmo che mette in moto l’azione organizzativa.
Ma l’elemento spesso trascurato nelle analisi è proprio quest’ultimo: l’entusiasmo. La disponibilità personale ad impiegare l’energia vitale nel lavoro, a “metterci del nostro”, è una condizione che appartiene alla persona, è separata da ciò che l’azienda può fare per attivare o inibire il nostro entusiasmo. I due elementi dell’engagement – la disposizione all’entusiasmo e i fattori situazionali – sono fortemente legati tra loro e interdipendenti, ma sono diversi. Uno appartiene alla persona, l’altro all’ambiente organizzativo in cui opera. Se si trattasse di matematica, diremmo che per cambiare il risultato dobbiamo intervenire non solo sul denominatore ma anche sul numeratore.
La questione centrale è che mentre le organizzazioni cercano di intervenire sulle condizioni del lavoro, sono fortemente mutate negli ultimi anni le aspettative soggettive e la rappresentazione di quell’esperienza centrale nella nostra vita che chiamiamo lavoro. Le persone desiderano un equilibrio diverso tra il lavoro e la vita privata, accettano con un crescente grado di insofferenza i climi organizzativi tossici, cercano relazioni nutrienti anche sul lavoro con colleghi e manager, desiderano percorsi di sviluppo professionale e retribuzioni che consentano almeno una vita dignitosa, tanto per citare le voci più note e immediate di un elenco consistente. È il numeratore che è cambiato molto da qualche anno. Se si vuole aumentare il livello di engagement delle proprie persone, dunque, occorre considerare e studiare con attenzione bisogni, esigenze e richieste di queste (e non presumere una conoscenza standard), prima di progettare l’offerta di benessere, che spesso insiste su voci di welfare gradite ma esterne all’esperienza del lavoro, senza troppa considerazione per la qualità della vita organizzativa quotidiana. L’esperienza del Covid ha accelerato i cambiamenti, la relazione tra le persone e il loro lavoro sta mutando in maniera rilevante e la propensione all’”entusiasmo” è dunque alimentata da elementi diversi.
 E qui vengo alla seconda questione cruciale che vedo spesso trascurata. Ancora poche aziende dedicano la necessaria attenzione alla conoscenza delle loro persone, condizione preliminare alla formulazione dei servizi di wellbeing, oltre che all’evoluzione dei sistemi di gestione e sviluppo delle Risorse Umane. Alcune aziende utilizzano le ricerche sul clima, che offrono molti elementi ma spesso hanno un alto livello di standardizzazione, e molte poche avviano indagini periodiche sui bisogni di welfare; meno ancora sono quelle che fanno uso delle pulse survey per chiedere alle loro persone, semplicemente, “come va?”, “com’è andata questa settimana?”, molto utili in particolare con le persone in smartworking. L’utilizzo integrato di questi strumenti di ricerca potrebbe effettivamente permettere alle organizzazioni di conoscere le proprie persone, di comprendere come cambiano nel tempo – anche in ragione delle diverse fasi della vita – le loro esigenze e preferenze.
E qui vengo alla seconda questione cruciale che vedo spesso trascurata. Ancora poche aziende dedicano la necessaria attenzione alla conoscenza delle loro persone, condizione preliminare alla formulazione dei servizi di wellbeing, oltre che all’evoluzione dei sistemi di gestione e sviluppo delle Risorse Umane. Alcune aziende utilizzano le ricerche sul clima, che offrono molti elementi ma spesso hanno un alto livello di standardizzazione, e molte poche avviano indagini periodiche sui bisogni di welfare; meno ancora sono quelle che fanno uso delle pulse survey per chiedere alle loro persone, semplicemente, “come va?”, “com’è andata questa settimana?”, molto utili in particolare con le persone in smartworking. L’utilizzo integrato di questi strumenti di ricerca potrebbe effettivamente permettere alle organizzazioni di conoscere le proprie persone, di comprendere come cambiano nel tempo – anche in ragione delle diverse fasi della vita – le loro esigenze e preferenze.
Su questa base, potrebbero progettare risposte più mirate per sostenerle. L’attenzione all’ascolto porrebbe ovviamente delle sfide in termini di coerenza nelle risposte ai bisogni emersi, ma l’esperienza dice che le organizzazioni stabilmente attente all’ascolto “organizzativo”, oltre che a quello manageriale, non fanno così fatica a predisporre risposte ragionevoli e efficaci.